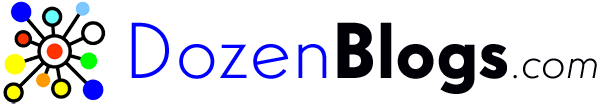Uno studio scientifico guidato da
Leonardo Tartaglia, ricercatore dell’Inaf – Osservatorio
Astronomico d’Abruzzo, propone una nuova interpretazione della
supernova Sn 2024bch, mettendo in discussione la classificazione
tradizionale di questo tipo di esplosioni stellari.
La ricerca, realizzata da un team interamente italiano con la
collaborazione delle università di Padova e dell’Aquila, ha
analizzato per 140 giorni la radiazione emessa dalla supernova,
esplosa a circa 65 milioni di anni luce dalla Terra. Le
osservazioni iniziali mostravano righe di emissione molto
strette, solitamente considerate prova dell’interazione tra il
materiale espulso dalla stella e un denso guscio di gas
circostante.
Tuttavia, l’analisi del gruppo di ricerca ha evidenziato che
l’energia sprigionata non deriva da questo meccanismo.
L’esplosione si sarebbe evoluta senza interazione significativa
con l’ambiente circostante. In altre parole, la supernova si è
comportata in modo “asociale”, liberando energia quasi
esclusivamente tramite processi radioattivi interni. La campagna
osservativa è stata condotta utilizzando diversi strumenti
dell’Inaf: il Wide-field Optical Telescope (Wot) da 67/91 cm a
Campo Imperatore e i telescopi Copernico (182 cm) e Schmidt (92
cm) della sede di Asiago. Il monitoraggio nello spettro
ultravioletto è stato possibile grazie al satellite Swift.
“Abbiamo adottato un approccio libero da preconcetti – spiega
Tartaglia – mostriamo che il motore principale dell’emissione è
la fluorescenza di Bowen, un meccanismo noto da decenni ma mai
applicato allo studio di oggetti di questo tipo. Il nostro
modello descrive tutte le fasi osservate della supernova”.
Secondo gli autori, l’assenza di interazione tra l’ejecta e
il gas circostante esclude che Sn 2024bch possa essere una
sorgente di neutrini ad alta energia, elemento rilevante per
l’astronomia multimessaggera.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA